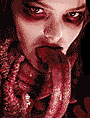|
||||||||||||||||||
| Picnic at Hanging
Rock, Australia, 1975 di Peter Weir, con Rachel Roberts, Anne Lambert, Helen Morse C’è stato un periodo in cui Peter Weir era vicino al Tempo Dei Sogni, lo percepiva, ci regolava il suo orologio. Che era fermo a mezzogiorno. Picnic ad Hanging Rock contiene gli stessi germi tematici che si ritroveranno due anni dopo nell’Ultima Onda, primo fra tutti la messa in scena di simbologie attinte da una mitologia precristiana, nel caso del film del ’77 quella aborigena. Il Tempo Dei Sogni, appunto. Come in una Grande Migrazione, anche il percorso del regista va dal nord a sud, da paese d’appartenenza a paese di destinazione; e se è l’Australia il punto di arrivo di un viaggio che è precipuamente culturale, quello di partenza non può non essere la Grecia antica. A scoprire un altro Tempo Dei Sogni. Il flauto di Pan di Gheorghe Zanfir è ufficialmente presentato sin dai titoli di testa: ufficialmente e di diritto entra il nome del Grande Dio Pan nel film, e in questa serie di considerazioni. Brucia, strega, brucia L’esaltazione della natura nei suoi aspetti meno culturalmente mediabili, ancorché asserviti ad un’estetica impeccabile e raffinatissima, è uno degli specifici stilistici di Picnic, domina l’incipit della storia come quello sperone basaltico domina l’Outback australiano. La Roccia Appesa, cioè sovrastante, incombente. Numen inest diceva un poeta latino, aleggia un nume. La sensazione è inequivocabile, perché è frutto di una nanotecnologia di dettagli perfetta; l’effetto, inevitabile. Picnic è un film a struttura debole - carente di tutto il baricentro, che nei thriller, o mystery story che siano, è necessariamente situato nel finale, in cui il payoff, la risoluzione del mistero, costringono l’autore a render conto di quanto promesso nel setup iniziale - perché il suo spirito propulsivo è tutto nei simboli, di cui trabocca letteralmente, simboli che verrebbero snaturati ad esser tradotti in situazioni articolate, hanno bisogno solo di pure immagini per essere evocati. La natura è il primo simbolo, il predominante, nella sua connotazione più eterogenea, irriducibile, antiumanistica. Le collegiali si avvicinano a quella natura come visitatrici da un altro pianeta, senza sapere, solo avvertendo, percependo. E c’è parecchio da percepire, soprattutto da questa parte dello schermo; come per un trucco “gestaltico”, l’orchestrazione registica di Weir rende in qualche modo la somma delle corde toccate maggiore delle stesse prese individualmente. Il sole chino sulle donne, che tocca senza premere, obliquo attraverso l’aria quasi brumosa, e la percezione subliminale di una foschia incolore che sfasa appena il vedere, sembrano in qualche modo suggerire anche sollecitazioni per altre zone dello spettro percettivo: odori, ad esempio ma anche percezioni finissime, meno sensoriali, presentimenti, intuizioni para-normali; magari quella che lo stesso Weir ha tentato di indicare globalmente come “una più sottile esperienza del reale”. Ottenuta anche mettendo un velo da sposa sull’obiettivo della macchina da presa. Le collegiali sono donne. È all’opera qui una specie di archetipico modello secondo il quale sono le donne le creature con un più intenso contatto con la dimensione ctonia della vita e del reale, più vicine alle profondità della terra che non alle elevazioni celesti, più pronte ad ascoltare Pan che Minerva. Più ninfe che vestali. Brucia strega, brucia: è il grido che ne verrà di conseguenza, di cui il cinema si ciberà rigurgitando capolavori come Dies Irae di Dreyer, o film importanti come The Virgin Suicides di Sofia Coppola. Perché come nel film di Weir si vede chiaramente, le donne sono un mistero e hanno segreti; sanno ritrovare una via che in qualche modo l’uomo ha perso, e forse non può più seguire. Il nobilgiovane inglese tenterà la scalata della roccia per ritrovare Miranda, ma le ferite che riporterà saranno visibili e profonde, e la salita stessa bruscamente interrotta. Caduta, discesa, abbandono La polarizzazione di tema e controtema è del tutto palese, è una dolorosa antitesi da un lato tra educazione di stampo vittoriano al graduale disconoscimento delle proprie radicali pulsioni animalesche, vitali in quanto naturali e naturali in quanto vitali; e il mesmerismo della Roccia, indefinito, panico, titanico, dall’altro lato. È in questa lotta che dobbiamo probabilmente ricercare la soluzione del mistero; non è una vicenda in background, è “la” vicenda, il conflitto. Weir ha dichiarato di aver volutamente cercato la strada dell’ipnosi, della fascinazione irrazionale, per timore che un pubblico troppo poco ammaliato dal film si risentisse per una carenza nel testo così ovvia: la mancanza di un perché, di un dove, di un cosa. La mancanza di una soluzione. Eppure è proprio il fascino dell’irrazionale l’indizio per la soluzione, ma è una soluzione che potrebbe lasciare interdetti gli amanti “del genere”, molto meno metabolizzabile del comodo wormhole di turno, l’immancabile varco spazio-tempo. “Cadono in un crepaccio” ammise il regista, costretto da un giornalista a dire quale fosse la sua chiave di lettura “da spettatore”. Discesa, pensiamo subito, non caduta. Nel continente più giovane politicamente, quindi più vecchio, più vergine di tutti, un budello antico milioni di anni che conduce chissà dove, “magari al centro della Terra”, dipinto entro una cornice naturalistica così carica da essere quasi un tributo alle atmosfere decadenti di Losey, non può non essere un Luogo, un varco per gli inferi, un viatico per quella parte di sé più di ogni altra messa in serio pericolo dall’ educazione di un collegio inglese per ragazze d’alta borghesia. La caduta è una discesa, è un ritorno, ma è anche, irreversibilmente, un abbandono. L’unico indizio che possiamo usare per tentare di seguire le tre donne è proprio questo metafisico assunto: la coincidenza tra micro e macro, tra orografia del paesaggio e geografia dell’anima, che non ha nulla di metaforico, non più di quanto Matrix sia una metafora della vita vera. “Se la mente muore, il corpo lo segue” dice nel film dei Wachowsky Morpheus (il dio greco del sonno, tra le cui braccia scivolano con fare rituale le studentesse…). La scomparsa delle tre giovani acquista quindi il sapore di un atto di ribellione estrema da parte di una natura (umana? extraumana? la distinzione perde di senso) stanca di essere ridotta a metafora, a contesto, oggettualizzata e stilizzata. Il punto non è dove siano mai finite quelle tre, ma perché ci siano finite. La caduta accidentale va bene come qualsiasi altra fine, non è la fine il mistero. Picnic è un thriller metafisico. Il richiamo di Pan E così l’orologio che si ferma a mezzogiorno in punto (ora che secondo la mitologia classica era impregnata di valenze e potenzialità magiche) significa lo scollegarsi da una struttura, quella del tempo e della misurazione delle attività umane per fini produttivi-pragmatici, che controlla e raffina ponderatamente ogni atto, ogni pulsione, normalizza e seleziona. Spogliarsi: le ragazze e perfino l’insegnante megera si disfano dei propri vestiti; ritorna il corpo non appena si uccide il tempo, si affaccia una visione sessuata della realtà, pagana, scabra, inquietante. Tutt’altro che il quadro di Botticelli menzionato ad arte nella storia: nulla di così pagano e panico avrebbe potuto comparire in un dipinto di quel pittore, e sentirlo nominato in questo contesto crea un contrasto efficace, significativamente antitetico. Il messaggio di Weir infuso in questa impressionante epifania panica è tanto più eversivo quanto più è inguainato in una forma che tocca vertici di classicismo, nell’impostazione formale: il flauto di Pan, la musica di Mozart, l’inizio del secolo diciannovesimo, ma anche il rigore dell’impalcatura narrativa, priva di qualsiasi concessione che sia anche solo uno sfogo di tensione. La tensione invece non trova valvole da cui defluire, chiude senza esplosione, si asciuga per ellissi, sfuma nella voce fuori campo che porta la chiusa della storia, nell’ammissione che no, al finale non s’è pensato. Il finale c’è eccome: gente che scompare, quando si trova, per caso o per causa, ad avere a che fare con strati dell’esistenza così sotterranei che non sospettava neanche di avere, così in profondità che non sono incrinati da parole, ragioni, equazioni. Strati che gridano, proclamano la propria esistenza, e infine pretendono. Il Grande Dio Pan si è svegliato e ha chiamato a sé tre donne. Protagoniste di una scena di orrore puro assolutamente memorabile, perché costruita con la grande arte della sottrazione. La processione di tre figure riprese di spalle, che, ondeggiando nell’innaturalezza di un passo rallentato cinematograficamente, scompaiono tra le fenditure della roccia senza mai voltarsi né prestare ascolto alle grida disperate della quarta compagnia, più pavida, meno pronta. Quello che non vediamo innesca la fantasia del mostro laddove sappiamo bene non doverci aspettare il mostro, non l’horror ma il dramma. Tre donne trasfigurate, stregate, anzi streghe. La strega è invisibile come la divinità a cui è devota (e Pan, che presterà le sembianze alle magre fantasie dei primi cristiani per aiutarli a costruirsi un proprio diavolo, era anche chiamato l’Invisibile). La strega, non serve vederla in volto per averne paura, ci ricorderanno 24 anni dopo Myrick e Sanchez. |
||||||||||||||||||