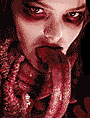|
||||||||||||||||||
| id., USA, 2001 di Brad Anderson, con Peter Mullan, David Caruso, Stephen Gevedon, Brendan Sexton III Ci capita di ritornare con la memoria a tutte le epifanie cinematografiche di questo ricco e variegato 2005, e di scorgervi nel bel mezzo un volto tormentato, i lineamenti scavati all’inverosimile, lo sguardo senza vita: è il volto di un operaio che dorme poco, un “macchinista”. Trevor Reznick. Trevor ha una faccia che non si dimentica; il suo personaggio da incubo è la carta vincente del film che Brad Anderson, regista trentenne, gli ha costruito intorno: peccato che poi L’uomo senza sonno non offrisse tutti i brividi che prometteva, letteralmente soffocato da un eccesso di ammiccamenti d’autore e da uno sfoggio tecnico in parte fine a se stesso. Dove invece l’eccezionale talento visivo di Anderson veniva davvero fuori era nel film precedente, quello che, constatata l’indiscutibile vocazione “nera” dell’autore, può a buon diritto rappresentare il suo esordio “di fatto” (in realtà, la sua spuria opera prima era stata addirittura una commedia). Session 9, del 2001, sposava una raffinata materia narrativa ad uno stile che si rivelava straordinariamente aderente ad essa, al punto da dominarla - di volta in volta assecondandola o “sfondandola” - come capita solo nelle regie degne di nome. E Anderson, autore “totale” - regista, co-sceneggiatore e montatore - stupiva davvero per la potenza che riusciva ad infondere ad una storia di suo già nerissima. La vicenda prende le mosse da un appalto per la rimozione dell’amianto da un fatiscente manicomio; lo ottiene un gruppo di operai guidato dallo scozzese Gordon (Peter Mullan); il lavoro li porterà faccia a faccia con loro stessi, e quel che è peggio con un edificio che fu teatro di morte. Dall’incipit del film viene subito fuori l’intento primario di Anderson: sfruttare il classico topos della haunted house per creare un universo malsano e disturbante. In questa direzione, è abile la trovata di connotare immediatamente l’edificio in senso metaforico, dopo un dolly iniziale abbastanza di prammatica: il manicomio viene infatti paragonato ad un grande pipistrello in volo, per via delle due imponenti ali del complesso, decisamente sproporzionate rispetto al corpo centrale. Basta già questo agli sceneggiatori per caricare ad arte quello che altrimenti sarebbe rimasto semplicemente il setting della vicenda; invece, esso viene subito introdotto addirittura come qualcosa di “vivo”. A questo punto il compito del regista era di rendere palpabile il “respiro” del manicomio, vero e proprio simulacro del Male risvegliato dopo un lungo letargo; va in questa direzione quello che è il principio stilistico del film, giocato da Anderson sulla continua mobilità dell’apparato filmico, complice quel prodigio di “leggerezza” tecnica che è la Sony ad alta definizione usata per il film: la macchina del regista moltiplica continuamente i punti di vista, proponendone di sempre nuovi ed “irreali”; essa passa da una stanza all’altra, da un piano all’altro, attraverso muri, pavimenti, colonne, finestre; non descrive lo spazio, ma piuttosto lo crea, disorientando lo spettatore che tenti invano di dominare l’ambiente. Così facendo, si trova spesso ad abbandonare i personaggi e l’azione in senso proprio, magari nel bel mezzo di un dialogo, sottolineando un’indipendenza “fisica” dai fatti narrati che diventa subito onniscienza; è il tipico doppio binario registico, aurea formula nella quale il senso si raddoppia e si moltiplica, andando a giocarsi sempre su due livelli, il filmico e il profilmico. In Session 9 questo accade continuamente: lo sguardo dello spettatore incorre in imprevedibili detour, e non gli è mai permesso di soffermarsi su alcunché, sempre pronto Anderson - il regista o il montatore - a staccare o a panoramicare su altro, insistendo sulle aspettative disattese e sul perpetuo tentativo di deviare l’attenzione del pubblico. Se l’ordito di Session 9 risulta così affascinante, è anche perché solidamente supportato da un’affascinante concezione del Male, descritto come entità aerea della quale sono fisicamente impregnate le pareti dell’edificio, e quindi letteralmente “respirabile” attraverso le polveri che i malcapitati operai sollevano col loro lavoro. Come dire, esso è sempre stato lì, in attesa, accumulatosi negli anni di apertura del manicomio, ricettacolo di fatti atroci e menti perverse. Adesso, gli serviva solo qualcuno che lo raschiasse via dalle mura; oppure - quel che è peggio - lo restituisse all’ambiente attraverso vibrazioni sonore, “liberandolo” dalle vecchie registrazioni delle sedute di ipnosi con un paziente schizoide. “Digging in the dirt”, scavare nello sporco, è, per dirla con Peter Gabriel, né più né meno ciò che si ritrovano a fare i protagonisti della storia. Anche qui, su due livelli differenti. Mentre lavorano alacremente per staccar via da pareti e pavimenti una delle più cancerogene sostanze conosciute, uno di loro si fa catturare dalla curiosità, e comincia a raschiare da quel luogo anche le memorie. Sporche e terribili. Parte la trama interna, quella di cui tutto il setting - emotivo e architettonico - è metafora macroscopica, quella che ci permette di fare la conoscenza della povera Mary, rinchiusa sin da ragazzina nell’ospedale psichiatrico a causa di un evento orribile sepolto nel suo passato e seppellito dall’oblio. Sarà attraverso l’ascolto dei vari nastri rinvenuti in un polveroso archivio che Mike (Steven Gevedon, co-sceneggiatore insieme ad Anderson) conoscerà, gradualmente, la storia di Mary e del Male che portava nascosto con sé, rivelato drammaticamente nell’ultima session di ipnosi, la numero 9, appunto. È proprio questa doppia faccia del Male a dare efficacia alla narrazione. È una cosa fisica, si respira, sono spore che si agitano nell’aria come un pulviscolo invisibile, surrettizio, ma reale. Ciò che affliggeva la piccola Mary - colpo di scena - non è fatto di psiche, non è di fronte ad un horror psicologico che ci troviamo. La minaccia è materiale anche se impalpabile, come l’amianto. Fino qui, niente di nuovo, si dirà, è il paradigma di molti film più o meno riusciti, uno fra tutti Poltergeist: è il luogo ad essere pernicioso, secondo l’assunto arcaico in base al quale fatti profondamente drammatici segnano il posto in cui sono accaduti, vi depositano il loro carico di negatività che in questo modo da fisico diventa metafisico, attraversa il tempo, si reitera, consolidandosi. Ciò che colpisce, l’originalità di Session 9, è nella costruzione attenta e dedita dell’humus umano su cui deve depositarsi il seme della follia e del caos per germogliare. Gordon è Peter Mullan, e questo fatto ci sembra di assoluto rilievo, perché Mullan regala a quello che altrimenti sarebbe stato un horror fra i tanti, un carico di umana sofferenza che provoca un’impennata drammaturgica di risonanza totale. Il volto di Gordon è un caleidoscopio di difficoltà e inquietudini mai esplicitate, ma in continuo contrappunto allo snodo degli eventi; Gordon ha una famiglia, una figlia piccola, e questo sembra causare in lui felicità e preoccupazioni in egual misura. Non brillano mai, i suoi occhi, del monocorde lampo di felicità che molti protagonisti di film simili hanno sempre stampato in faccia. L’affetto sembra sempre smorzato da una strana incapacità di saper accettare il suo ruolo di marito e padre per quello che è, o dovrebbe essere. Gordon è tormentato. Ha problemi economici. Aggiudicarsi l’appalto del manicomio significa per lui affrontare una sfida ai limiti delle proprie capacità, ed è costretto a proporre tempi impossibili perché quei soldi gli servono, disperatamente. Anderson deve aver voluto bene alla squadra di pulizie che ha creato, perché nessuno dei suoi componenti è tratteggiato in maniera sbrigativa, non ci sono stilizzazioni da cliché; ci sono risentimenti e inimicizie che si agitano tra i suoi membri, e che non tardano a farsi sentire. Forse ci sono anche segreti. È in questo milieu umano descritto con singolare efficacia che viene a far presa l’ospedale, sia come luogo che come meta-luogo. E forse non è un fatto casuale che i personaggi della storia siano tutti appartenenti ad una stessa classe sociale facilmente identificabile come ceto operaio, o comunque riconducibili ad un sottobosco lavorativo decisamente vicino al proletariato industriale. I conti tornano. Perché a questo punto la presenza di Peter Mullan (attore “loachiano” e autore con una dichiarata sensibilità proprio per l’universo emotivo di quella classe sociale) potrebbe essere letta sotto l’egida di un patto stretto tra attore e regista in virtù proprio di tale comune attenzione verso un cinema sociale, quale che siano i suoi referenti o connotazioni “di genere”. In fondo il machinist Trevor Reznick de L’uomo senza sonno era ancora un operaio, né più né meno. Anderson ha compreso appieno le potenzialità insite nella chimica tra umana sofferenza e sovrumana immanenza del male, né si limita a tratteggiare una sofferenza genericamente detta, ma cerca in qualche maniera di connotarla, di restituirgli coordinate perfettamente riconoscibili da un punto di vista sociale. La lotta per sopravvivere in un mondo economicamente ostile, ad esempio, in cui avere una famiglia, una moglie dolcissima e una bellissima figlia non sono di per sé garanzie di una patinata, analgesica serenità. Quasi fosse un punto di vista privilegiato, quello dei deboli e degli umiliati, per osservare le devastazioni del caos incombente, per esaltarne portata drammatica ed effetto scenico. Proprio in quei “deboli e umiliati” in cui vive e perpetra i propri orrori un certo Simon, entità residente nei cunicoli dimenticati di una mente e di un vecchio ospedale psichiatrico. |
||||||||||||||||||