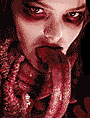|
||||||||||||||||||
| The Front Page,
Usa, 1974 di Billy Wilder, con Jack Lemmon, Walter Matthau, Susan Sarandon, George Burns Nella prima metà degli anni ’70, quando il cinema americano stava progressivamente cambiando pelle ormai rassegnato a consegnare lo scettro del potere a nuovi grandi autori come Coppola, Friedkin, Scorsese, Spielberg, Lucas ecc., un cineasta senza tempo come Billy Wilder ha prepotentemente affermato la sua identità di autore classico con quello che è forse il suo film più personale, o meglio più programmaticamente ideato per risultare il manifesto estetico di un tipo di cinema ormai al tramonto. In un’epoca in cui si stava definitivamente affermando l’uso degli effetti speciali – pensiamo alla già avvenuta rivoluzione di Kubrick e di 2001: Odissea nello spazio, al successo planetario de L’esorcista, oppure ai futuri arrivi dello squalo di Spielberg e della saga stellare di Lucas - ed un nuovo tipo di realismo che andava contro le regole delle major e del periodo classico – basta vedere i primi film di Scorsese o i migliori lavori dello stesso Friedkin, girati fuori dagli studi e secondo regole più improntate all’immediatezza dell’accadere filmico -, Prima pagina si pone come una pellicola che rispecchia in pieno un modo di fare cinema appartenente ad un universo produttivo che si stava eclissando. Innanzitutto, Wilder imposta un tipo di messa in scena di stampo assolutamente teatrale, e quindi contraddicente tutti i crismi della “Nuova Hollywood”: il che vuol dunque dire ricostruzione accurata degli interni in studio, e, principalmente, la possibilità di sviluppare di conseguenza una regia classica, invisibile nel non sottolineare con alcun intervento prettamente filmico quanto accaduto davanti alla macchina da presa. Tale tipo di accostamento al mezzo/cinema viene però accentuato in questo caso dall’autore de L’appartamento fino a farsi preciso e cosciente testamento estetico del suo creatore: in Prima pagina infatti si assiste ad una stilizzazione che, partendo dalla volontà del mezzo di nascondersi agli occhi dello spettatore, supera questa linea attraverso un processo di coerente sviluppo/accentuazione dello stesso. Sfruttando al massimo l’impianto claustrofobico degli interni e l’affiatamento di un gruppo di caratteristi di compassata sapienza, il regista costruisce una serie di inquadrature fisse che diventano veri e propri quadri viventi; mai come in questo caso l’accezione di piano/sequenza è riuscita ad esplicitarsi nella sua forma più pura ed allo steso tempo semplice, quella di una macchina da presa che filma impassibile, in tutta la possibile estensione neutra della sua durata spazio/temporale, ciò che viene straordinariamente creato davanti ad essa: soprattutto nelle incredibili sequenze all’interno della sala-stampa della prigione, assistiamo ad inquadrature che durano svariati minuti e si imprimono nella memoria come vere lezioni di cinema. Wilder organizza tutto lo spazio dell’immagine in una superba sarabanda, creata principalmente da un gruppo di attori che sfruttano al meglio una sceneggiatura i cui dialoghi sono un capolavoro di ritmo comico: in questo modo non soltanto due istrionici mattatori come Lemmon e Matthau, ma anche tutti gli strepitosi caratteristi comprimari, sono riusciti ad infondere alla pellicola il ritmo necessario. Chi si accosta alla visione di queste scene si trova a dover spostare continuamente l’attenzione da un angolo all’altro dell’inquadratura organizzata da Wilder, incapace di staccarsi dal vortice di visione/parola ideato dal cineasta. Volendo analizzare il semplice aspetto estetico, nessun film di Wilder quanto Prima pagina ha sfruttato con così precisa abnegazione tutte le potenzialità del rapporto tra la durata dell’inquadratura e la possibilità di inventare cinema all’interno della stessa. Regista supremo tra i grandi cineasti classici, Wilder impartisce una lezione cinematografica di importanza a nostro avviso fondamentale: ha dimostrato che, attraverso la sapienza nell’organizzazione del movimento interno al fotogramma, l’efficacia estetica di un film può anche prescindere dalla partecipazione attiva del metteur en scene. Questo saper creare ritmo visivo dentro l’immagine, che può anche significare liberarsi dalla spettacolarità spesso fine a se stessa del movimento della macchina, trasforma perciò Prima pagina in una sorta di testamento ideologico. Con questo film Wilder ha firmato probabilmente il suo audace, ultimo capolavoro, e non soltanto sotto il mero lato estetico: tutto il gioioso e sagace sarcasmo del cineasta si esplicita in una messa in scena di cui abbiamo già analizzato i principali stilemi, ma che si poggia poi su una struttura narrativa di inaudita solidità drammaturgica; oltre all’innato talento comico/sovversivo di Wilder, si registra anche un accento maggiormente lugubre ed amaro; temi socio/politici che in pellicole passate attraversavano le storie come discorsi presenti ma comunque sotterranei, in Prima pagina si fanno invece esplicita dichiarazione d’intenti: la pena di morte, il degrado dell’autorità, il potere coercitivo dell’informazione. La solita ironia del genio adesso si fa tetro sarcasmo, che in non pochi momenti arriva a sfiorare l’inquietudine del grottesco. Wilder ed i suoi alfieri Lemmon e Matthau scelgono in questo caso di giocare con temi scottanti e con personaggi dalle sfaccettature maggiormente oscure rispetto a quelli affrontati in precedenza. Prima pagina è tutt’altro, anzi molto altro rispetto alla scatenata ed irresistibile pochade che costituisce il suo involucro filmico: attraverso una forma di spettacolarità maggiormente inerente alla forma primaria del mezzo cinematografico - l’inquadratura - il film si pone come riflessione caustica sulla spettacolarità endemica nella società americana: che si tratti di cinema, di informazione o di giustizia sociale, tutto viene alterato in un universo visivo poi ridicolizzato in carnevale verbale di perfetta funzionalità, soprattutto quando si tratta di svelarne l’insensatezza. |
||||||||||||||||||